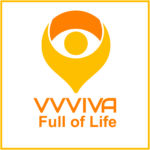Un racconto di Maria Eugenia Sciuto.
Accatastate sedie. Mobili vecchi, bici, una sull’altra.
Un gioco finito male.
Legati i polsi, dietro la schiena, in quattro.
Ce lo siamo lasciati fare, pensando che sarebbe durato poco, il tempo di uno scherzo.
Ma i tempi sono lunghi, la percezione reale. Ed è quasi buio, ora.
Dalle grate, una piccola finestra in vetro, tanto…e ferro, arrugginito e posto lì con incuria, non entra più luce. E noi lì, immobili, muti. Sento i polsi farmi male, mentre cerco di liberarmi. La corda tira, è spago rozzo e nodoso. Però si sfilaccia. Allora tiro più forte, dimeno i polsi, sono agitata, ho paura. E sfregano contro quei nodi. Si allentano. Immobili gli altri. Un’accettazione incomprensibile, per me.
Non conosco i tempi che mi separano dalla libertà, anche se chiusi lì dentro, ma a un certo punto sono con le spalle e le braccia indolenzite, le mani davanti. Tasto ogni cosa, inciampo. Cerco di memorizzare gli oggetti che prima avevo visto, senza dar loro alcun peso, senza attenzione. Cammino, pochi passi, finché non sbatto contro un mobile.
Ora lo ricordo. Lo tasto. Legno ruvido e schegge nelle mani. Le ritraggo. Poi cauta ancora tocco. Apro i cassettoni. Vuoti. Li richiudo appena un po’, per farne scalini. Appoggio le mani sul mobile, ad altezza del mio petto. Piccola, gracile, furiosamente impaurita. Poi metto un piede sul primo cassetto, mi faccio forza con le braccia, mi aggrappo. Una scheggia nella mano. La sento perfettamente, ma non la ritraggo più. Metto l’altro piede sul secondo cassetto, mi muovo in fretta, ho paura che il mobile cada, che faccia rumore, che qualcuno fuori lo senta, quel rumore.
E che quel qualcuno sia il figlio del conte, quello che ci ha legato e rinchiuso qui.
Devo arrivare in fretta, su. E in effetti ci arrivo, scorticata. Mi metto in piedi. Gli altri bambini al mio rumore chiedono cosa succede, cosa sto facendo. Non rispondo. Sono in piedi, ora. Tocco in alto, arrivo alla grata.

Cerco di toglierla, era solo appoggiata, gioco facile. Oppure è la paura di rimanere lì, al buio, che mi terrorizza. Fatto sta che l’adrenalina corre, il respiro è a mille. Cerco un appiglio per aprire il vetro, sopra la porta del garage, oltre la grata. E c’è un piccolo gancio, lo tolgo. La apro, fulminea. Mi arrampico. Esco, per metà.
Poi interamente. Mi butto giù. La ghiaia mi accoglie. Scorticata, ora anche ginocchia e gomiti. Ho male, non capisco dove, ma mi sento come trafitta, ovunque.
Levo lo sguardo da terra, mi alzo. Non c’è nessuno. Nessuno che possa aiutarmi, chiedermi cosa ci faccio in terra. Per fortuna non c’è nemmeno il figlio del conte.
Nel giardino ghiaia e auto. Cemento, poco verde e siepi.
Mi bastano pochi passi, di corsa, quattordici.
Li ho contati, molti anni dopo, quando sono entrata una volta, l’ultima. Non abitavo più lì, i miei genitori avevano venduto per comprare una casa più accogliente, qualcosa che potesse accoglierci tutti, più vicina al mare. Ero tornata solo una volta. Per allontanare quella sensazione orribile, da me, di quello che era successo, molti anni prima. Ero entrata dal secondo cancello, più piccolo, posto nel retro. Una striscia di cemento e prato a entrambi i lati. Siepi dietro le quali mi nascondevo da bambina, giocando a nascondino con mia sorella. E alla fine di quella striscia di cemento un portone di vetro opaco e ferro, con accanto una bottoniera in metallo. Varcata quella soglia, a pochi passi e diametralmente opposta, l’altra entrata. E in mezzo l’ascensore, accanto ad esso, le scale. L’altra porta: legno e un occhiello per una vecchia serratura, Viro.

Ho corso quei quattordici passi, con la speranza che la porta fosse aperta, che non avrei incrociato nessuno, che l’ascensore fosse lì e che sarei salita al secondo piano, avrei dato l’allarme, mi avrebbero aperto, avrebbero liberato i miei fratelli ed Enrico Boicelli, il ragazzo con cui giocavo da piccola, rinchiuso insieme a noi. La porta era socchiusa, insperatamente.
E l’ascensore non tardò ad arrivare. Mi sembrò eterno, il tempo. Nessuno per le scale, suonai. Papà mi aprì, dissi tutto. Scese, si precipitò giù per le scale, io richiusi la porta.
Mi precipitai da mia madre, in camera sua. Continuavo a girarmi, continuavo a guardare, controllavo che la porta d’ingresso fosse veramente chiusa, che nessuno sarebbe più entrato a prendermi, a portarmi via. E le parlai, piangendo. Dopo poco a casa sono saliti i miei fratelli. Non ci siamo detti nessuna parola, non ci siamo guardati, se non per pochi istanti. Impauriti. Sembrava un gioco, poco più grande di noi.

Papà non c’era. È arrivato parecchio dopo. Non osavo chiedere, avevo paura di tutto.
Ha parlato lui, la sera a cena. Una tavola rotonda, di legno, a tavola in sette, come tutti i weekend : papà, mamma, noi tre e i nonni materni.
«Ho preso l’ascensore, dopo. Fino all’ultimo piano. Mi ha aperto il cameriere, ho chiesto del signor… »
A papà davano noia i titoli, conosceva solo la legge, la nobiltà d’animo, la famiglia: i suoi valori.
«Il padrone sta pranzando, non posso disturbarlo», mi ha risposto secco.
«Allora l’ho scostato, bruscamente, con furia. Era d’impaccio tra me e lui. È finito contro la libreria. Mi sono diretto in sala, era a tavola, con la moglie e il figlio. Mi ha guardato come avesse visto un estraneo in casa, un’invadenza inopportuna.»
«Cosa hai fatto?», ha chiesto la mamma.
«Gli ho sparecchiato la tavola in faccia. Ho preso un lembo di quella stoffa imbandita, l’ho tirato con forza, ho fatto saltare per aria tutto.»
«E poi, papà?»
«Se suo figlio osa toccare un‘altra volta uno dei miei figli, rinchiuderli da qualche parte o solo rivolger loro la parola non mi limiterò a buttarvi in faccia piatti e bicchieri. Nessuno tocca la mia famiglia. Sono stato chiaro?»
Papà è un avvocato. Un uomo di legge.
Me lo ripete sempre, so che è così.
L’ho sempre saputo, fino a quel giorno. E nei giorni fino ad oggi. Però so che quel che ha affermato era vero, lo è ancor oggi. Qualcosa di non scritto e insito nelle antiche famiglie.
Un codice silenzioso, non serve alcuna decodificazione, nessun linguaggio cifrato.
Come in ogni famiglia che sia nata nel secolo scorso, una legge non scritta.
Poche, lo sono.
Si perpetrano, salde, mai scalfite.
Nessuno tocchi la famiglia.
Solo molti anni dopo, in una conversazione a cena, papà ci ha detto tutto.
Qualcosa mancava. Qualcosa non mi tornava.
Sono passata più volte sotto quella casa, in viale Volturno 4, a Cervia.
E puntualmente alzo gli occhi a quel terrazzo, il mio.
Sono piccola, ho capelli neri, ricci, non hanno forma. Un groviglio da Erinni. Vedo le luci, rivedo quel tavolo, dentro. La cucina, piccola, le due poltrone in vimini e il tavolino, le luci da lettura, la libreria, le sedie in legno e corda, attorno al tavolo tondo. La luce più piccola in cucina sopra ai fuochi, la nonna che fa il ragù.

Il profumo della sera, i tramonti sul terrazzo, aspettando la cena, le chiacchiere, guardando in giù, per strada, chi sarebbe uscito. Poi abbasso lo sguardo, gli occhi vanno dritti al garage.
Le grate ora mi sembrano piccolissime, fitte.
Mi chiedo se ricordo male.
Se le hanno cambiate.
E ripercorro gli stessi anni, mentalmente, non tralasciando alcun particolare.
Sono fuggita, sono riuscita a liberarmi, sono viva, siamo tutti fuori da lì.
Eppure una parte di me è ancora legata tra quelle mura e armadi e legno che fa male, mi scheggia mani e testa.
Quando sogno male, quando ho gli incubi, sono lì.
Ripeto tutto, fino all’entrata in ascensore. Mi dico salva, ma quella scatola di metallo non si ferma al secondo piano, anche se ho spinto il tasto 2, non si apre, lì. Rimane chiuso, si apre all’ultimo, al quarto. E di fronte la porta socchiusa di chi mi ha legata.
So che la realtà è stata diversa, ma ai sogni non importa.
«Non vi ho detto tutto, non era necessario sapere tutto. Nemmeno oggi ve lo dirò. Non vi ha più toccato, non ha più nemmeno alzato lo sguardo, al vostro passaggio, di ognuno di voi. Nessuno di noi ha più incrociato i loro passi, in cortile, per le scale o altrove. Gli ho detto di non toccare la mia famiglia, che sono un uomo di legge. Ma che avrei dimenticato di esserlo, fosse successo qualcosa a voi. Che non sarei passato attraverso i tribunali, i codici scritti, le leggi. Che anche loro avevano un figlio, solo uno.»
Forse ancora qualcosa, che non ci ha detto, rimane tra i pensieri di un uomo vecchio, canuto, che ha uno sguardo dolce e le lacrime agli occhi, quando gli sorrido.
L’ho capito, allora. Lo capisco, ancor più oggi.
Ho tre figli, insegno Lettere, la mia vita sa di regole scritte, codificate.
Tranne una.